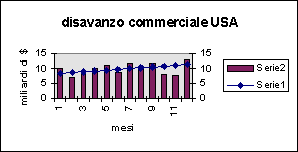 Figura
1
Figura
1
ECONOMIA FASE
1. Sintomi di un malessere
Nonostante le promesse continue di un futuro radioso (benessere, occupazione, rilancio economico, etc.), l’economia internazionale sputa come un motore ingolfato ormai da un decennio. Accade così che, in un periodo in cui tutti gli addetti ai lavori spandono un mieloso ottimismo sulla ripresa, tutte le borse, quella statunitense in testa, incontrino una brutta e significativa battuta d’arresto (cfr. Il Sole 24 ore, 12 settembre 1997, pp. 1, 9 e 31). A sentire gli economisti e i finanzieri la ripresa è perennemente alle porte, occorre solo lasciare al sistema delle imprese un po’ più di mano libera, sciogliere lacci e lacciuoli che imbracano il rigoglioso fluire della congiuntura economica e ben presto, molto presto se ne vedranno i risultati: crescita della produzione, ripresa degli investimenti, creazione massiccia di nuovi posti di lavoro, benefici salariali e di reddito per tutti e così via promettendo. Ma il refrain è lo stesso da oltre un decennio e questi fatidici, quanto miracolosi risultati, non si vedono; eppure gli imprenditori e gli operatori economici si sono visti liberare di tantissimi vincoli, specie nelle modalità di prestazione del lavoro, e possono vantare una libertà di manovra che era loro sconosciuta ormai da oltre mezzo secolo. Anzi, a ben guardare il panorama mondiale, i segni non sono incoraggianti: il tenore di crescita è debole in tutti i paesi (in alcuni si respira pesante aria di crisi), il mercato mostra continui segni di stanchezza e persino le famose locomotive dell’economia internazionale (USA, Germania, Giappone, le tigri asiatiche, etc.) ansimano vistosamente.
Per di più sinistri scricchiolii provengono dalle pieghe profonde del sistema economico e fatti apparentemente irrazionali affiorano alla cronaca quotidiana. Su questi ultimi conviene soffermarsi un po’, perché, se pure rispondono ad una logica interna all’attuale assetto economico, non possono non rivelare quanto quest’ultima sia distorta e porti al suo interno i germi patogeni forieri di una crisi epocale.
1.1 Wall Street
A cadenze quasi periodiche la borsa principe accusa brusche cadute in concomitanza con risultati positivi provenienti dal mondo della produzione. Un aumento dell’occupazione, una crescita rilevante del volume produttivo, un abbassamento del tasso di sconto disincentiva immediatamente gli investitori e i titoli quotati crollano. Proprio a fine marzo la borsa statunitense ha imboccato un’epoca di crisi che gli analisti prevedono lunga e profonda (Il Sole 24 ore, 1 aprile 1997, p. 25); e ciò in presenza di dati confortanti provenienti dal mondo della produzione, dati che confermano in pieno un quadro abbastanza roseo per il futuro economico degli USA.
È ovvio chiedersi come possano coesistere un buon andamento della congiuntura ed una crisi dei mercati finanziari. L’apparente ossimoro non è di facile soluzione, ma comporta riflessioni la cui soluzione risiede al di fuori dell’attuale panorama delle teorie economiche. Il capitale finanziario teme surriscaldamenti della congiuntura in quanto potenzialmente inflazionistici e chi investe prestando denaro desidera che questo gli torni monetariamente maggiorato degli interessi, senza che questi ultimi vengano corrosi dall’inflazione. Così le banche centrali, templi del moderno capitale finanziario si muovono con un obiettivo fisso: contenere l’inflazione anche a rischio della recessione.
Greenspan annuncia infatti che la Fed alzerà il tasso di sconto, gettando acqua sul fuoco del momento favorevole per l’economia USA (Il Sole 24 ore, 2 aprile 1997, p.3). Appare, quindi chiara la contraddizione tra gli investitori di borsa (il capitale finanziario, che occupa i gangli vitali dell’economia mondiale) e l’economia intesa come luogo della produzione. Di altre profonde differenze parleremo in seguito.
1.2 Gran Bretagna
Non passa giorno che qualcuno non tessa le lodi del modello inglese, il paese che per primo (se si esclude il Cile di Pinochet) ha imboccato la via neoliberista del monetarismo friedmaniano, traendone pare, dopo anni di durezze sociali, il sale di una sicura e solida impostazione economica. Sui dati e sulla loro reale consistenza ed interpretazione torneremo. Sta di fatto che alla City di London si decidono molti destini e non solo economici: sul giudizio dei suoi operatori si incagliano le manovre economiche dei governi europei e talvolta loro stessi (non quello tedesco però!). Il concentrarsi del capitale finanziario nella capitale britannica, fatto indubbio, può essere visto come un beneficio solo con qualche non trascurabile difficoltà. E’ appena il caso di ricordare che la Gran Bretagna ha iniziato la propria esperienza neoliberista nel 1979 occupando un solido quarto posto tra i principali paesi produttori ed ora si trova decisamente al quinto, sorpassata dall’Italia.
Sono gli effetti di quanto già osservato. A dicembre la borsa inglese ha subito un brusco tracollo a seguito della notizia di una sensibile crescita dei consumi. Il capitale finanziario teme il benessere delle popolazioni, perché la circolazione delle merci genera inflazione, ma così penalizza la produzione e genera deindustrializzazione.
1.3 La sindrome di babbo natale
Il basso tenore degli acquisti, la depressione dei mercati interni, la chiusura di tanti piccoli esercizi sono all’ordine del giorno. Nelle scorse feste natalizie le lamentele dei commercianti si levavano di continuo: Ma il problema del polso stanco del commercio al minuto non coglie solo il dettagliante, se Berlusconi accusa i comunisti di boicottare volutamente la Standa per i propri acquisti.
Il fatto reale è che tutti i mercati mondiali accusano fiacchezza dei consumi, e ovunque cala la propensione all’acquisto e al risparmio, anche in Italia tradizionale paese di risparmiatori; questo per il semplice fatto che la compressione del potere di acquisto della grossa maggioranza della popolazione, se spinge larga parte di essa oltre la soglia del malessere economico o addirittura dell’indigenza (stiamo parlando dei paesi industrializzati), consiglia a tutti molta prudenza nell’uso del denaro e l’incertezza del futuro, pur sempre più presente, non si riversa sul risparmio per carenza della materia prima.
Le merci trovano sempre meno acquirenti (Italia e Spagna incentivano sostanziosamente la rottamazione di veicoli vecchi per sostenere l’asfittico mercato dell’auto) e ciò, ovviamente, deprime la produzione e gli investimenti, limitando fortemente le prospettive dei paesi, come l’Italia, che hanno adottato modelli esportativi (non è un caso che tali provvedimenti di fleboclisi vengono alla chiusura del 1996 anno in cui le esportazioni italiane sono calate dello 0,3%). Se tutti i paesi adottano politiche recessive per contrastare l’inflazione, il mercato mondiale tende ad essere impossibilitato a chiudere adeguatamente il ciclo della produzione: la crisi è sempre alle porte.
2. Da Keynes al dopo Keynes
|
Tecnologia |
Produzione |
Mercato |
Struttura |
Controllo |
|
|
2.1. Fino agli anni '70 |
elettromeccanica |
fordismo |
oligopoli |
stato-nazione |
moneta |
|
2.2 Dagli anni '80 |
sei tecnologie |
ciclo frammentato |
competizioni per segmenti reticolo di aziende |
aree omogenee |
? |
Lo schema soprariportato è un utile riferimento per comprendere cosa si intende per globalizzazione dell’economia.. Riassume nella riga 2.2. le teorie correnti sul primato del mercato, evidenziando, grazie al confronto con la riga 2.1., i mutamenti avvenuti negli ultimi tre lustri nell’economia mondiale, rispetto al modello dominante precedente della regolazione fordista. Scopo della presente indagine è quello di scoprire se quello che viene presentato come l’attuale modello di funzionamento (riga 2.2.) sia coerente, se proponga un assetto stabile e se sia in grado di perpetuare se stesso per un tempo ragionevole, come ha inequivocabilmente fatto quello che l’ha preceduto e le cui cause di crisi non appaiono a tutt’oggi sufficientemente indagate.
Analizzando in breve dettaglio la riga 2.2. si possono fare le seguenti, rapide considerazioni. È finita la lunga fase della predominanza della tecnologia elettromeccanica, che insieme alla chimica aveva costituito il volano della seconda rivoluzione industriale a partire dalla fine del secolo scorso; viene sostituita quale asse dello sviluppo da un gruppo di tecnologie (o settori produttivi) a maggiore redditività di capitale (informazione, aereospaziale, tecnologie ambientali, elettronica, informatica, telecomunicazioni), i cui intrecci sono fittissimi.
Ad una struttura legata allo stato borghese settecentesco ed incentrata sul controllo oligopolistico della produzione organizzata sul modello sociale e di fabbrica fordista, si sostituisce un sistema aperto in cui convivono a stretto contatto aree di grande sviluppo con aree depresse (non statiche nel tempo), sulle quali si disperde il ciclo produttivo, con la conseguente accesa concorrenzialità su ciascuna fase di esso anche settoriale; le aziende si collegano in un reticolo e non più verticalmente, il che amplia la flessibilità della struttura a limiti impensabili, con la possibilità di rapide ascese e cadute delle zone di produzione, con la conseguente obsolescenza delle economie di nicchia.
Ma la cosa più rilevante per lo scopo prefisso è la casella terminale della riga 2.2.: il nuovo panorama non possiede alcun elemento di controllo, o meglio le teorie più accreditate non ne individuano alcuno. Giunge così alle sue estreme conseguenze il liberismo, in quanto il sistema si può autoregolare solo in virtù delle spinte riequilibratrici del mercato, quello però globale; non era così neppure nelle teorie di Adam Smith (il controllo doganale rappresentava una politica attiva di controllo sull’evoluzione del mercato) e neppure in quelle più recenti di Milton Friedman (il controllo della massa monetaria da parte dell’istituto di emissione, rappresentava una leva di governo economico, sopravvissuta dal periodo keynesiano).
3. La meteora toyotismo
3.1 Alcuni elementi di 2.1. e altri di 2.2.
Un caso a parte, ma che fornisce buoni spunti di riflessione, è quello dell’economia giapponese. Anche ad uno sguardo superficiale appare subito evidente che in esso convivono elementi molto eterogenei. Elementi tipici del capitalismo keynesiano (controllo oligopolistico, struttura produttiva verticalizzata) convivono con elementi post-moderni (innovazione tecnologica, finanziarizzazione, flessibilità della prestazione d’opera). Questa miscela ha prodotto una forma di capitalismo molto aggressivo, che ha segnato successi economici a ripetizione, la cui forza era da ricercare principalmente nella particolare situazione di sfruttamento della locale classe operaia (alta preparazione tecnologica, orari elevati, assenza di ferie, dedizione agli obiettivi aziendali, quadri intermedi e dirigenti di basso livello in situazione di esasperata concorrenza). Eppure recentemente anche il capitalsimo nipponico ha mostrato segni di decadenza: minore capacità di penetrazione nei mercati esteri (l’eccezionale surplus della bilancia commerciale segnato nell’agosto 1997, riportato ne Il sole 24 ore, 18 settembre 1997, p. 1 e p. 7, è più che altro frutto del basso profilo della congiuntura produttiva e dell’eccezionale disavanzo commerciale statunitense, delle cui importazione il Giappone beneficia particolarmente, anche se la concorrenza dell’Europa e quella crescente della Cina tende a mordere [cfr, Il Sole 24 ore, 19 settembre 1997, p.9]), crisi politica della tradizionale leadership liberale coinvolta in scandali, tassi di crescita al di sotto della media dei paesi industrializzati, bilancia commerciale mediamente in attivo poco marcato, fino a segnare un disastroso -2,9% (superiore ad un calo dell’11% su base annualizzata) del PIL nel secondo trimestre del 1997 (cfr. Il Sole 24 ore, 12 settembre 1997, p.9, 17 settembre 1997, p. 9).
3.2 Tecnologie avanzate e struttura feudale
Se i sintomi della crisi hanno caratteristiche simili a quelle che hanno investito gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la vecchia Europa, le cause devono pur avere fisionomie diverse, se talmente diversa è la complessiva struttura sociale e produttiva del Giappone. In quest’ultima, infatti, convivono non solo elementi di fasi capitalistiche diverse, ma anche resti di strutture molto più arcaiche, protocapitalistiche o addirittura feudali. La manodopera giapponese, per esempio, dipende totalmente in molti casi dall’azienda, sia per quanto concerne gli acquisti (spacci aziendali), sia addirittura per l’organizzazione del poco tempo libero. La mobilità sociale è ridottissima. Le futuribili conquiste della tecnologia concernono solo la vita delle grandi metropoli e sono penetrate solo marginalmente nel mondo rurale. Le concezioni di vita sono ancora ancorate a valori tradizionali, decisamente in contrasto con la società aperta connaturata allo sviluppo capitalistico.
3.3 Controllo non finanziario
C’è ancora una caratteristica che marca fortemente la struttura capitalistica nipponica, differenziandola fortemente da tutte le altre. A dominare il mondo dei paesi industriali avanzati è assurto sempre più prepotentemente nel corso di questo secolo il capitale finanziario. Nella sua versione anglosassone, esso è indipendente dal capitale di rischio o di intrapresa e lo controlla tramite la borsa, le banche, il prestito e infine tramite suoi rappresentanti nei consigli di amministrazione. Nella sua versione europea e più precisamente tedesca, il capitale finanziario è intrecciato fortemente con quello di rischio: spesso è la banca stessa che interviene nel mondo dell’impresa con propri capitali (come storicamente ha sempre operato la finanza tedesca), senza l’intermediazione del prestito, che rende meno diretto il rischio dell’investimento. In Giappone il capitale finanziario è strettamente in mano ai grossi capitani d’industria, che si comportano come finanzieri nel mercato estero dei capitali. Esso è l’unico paese industrializzato (con la parziale eccezione dell’Italia) in cui sopravvive il capitalismo delle famiglie.
3.4 Fattori di crisi
È giunto quindi il momento di chiedersi quali fattori possano aver determinato il declino di un modello che era apparso inarrestabile nella sua espansione fino a pochi anni fa, ed in grado di dispiegare una concorrenza con gli altri capitalismi, che solo misure protezionistiche potevano contrastare.
3.4.1 Innovazione di importazione
Una prima riflessione riguarda la qualità dell’innovazione tecnologica. Il Giappone ha perso durante gli anni ottanta la sfida tecnologica con gli Stati Uniti, nel momento in cui cioè le restrizioni finanziarie imposte dall’Amministrazione Reagan avevano compromesso fortemente le capacità dei centri di ricerca delle Università e la crisi delle esportazioni aveva ridotto la quantità di risorse che le multinazionali potevano riversare sui propri centri. Sia nel settore dell’elettronica VLSI, sia nella produzione di software, sia nell’utensileria computerizzata, sia nel design, sia nelle biotecnologie, le capacità di autonoma propulsione si sono rivelate minori del previsto e soprattutto minori di quelle che gli strateghi giapponesi auspicavano all’inizio del decennio. Per cui nei settori strategici della produzione il Giappone è rimasto in buona sostanza un importatore di innovazione, anche se utilizzatore geniale di detta importazione. Ma chi non detiene le redini dei prodotti di punta, alla lunga è costretto a cedere il passo e ad accodarsi.
3.4.2 Debolezza del mercato interno
Il regime della compressione salariale, la compartimentazione del mercato, la saturazione di consumi fortemente orientati su alcuni prodotti non legati ad un pieno godimento della qualità globale della vita, quanto invece ad un modello di tecnologizzazione forzata della vita domestica, hanno reso via via più asfittico il mercato interno. Nel contempo il modello marcatamente esportativo ha incontrato ostacoli nella politica doganale protezionistica degli altri paesi industrializzati. La cooperazione di questi due fattori ha costituito una strozzatura insuperabile per la struttura produttiva nipponica.
3.4.3 Capitani d’industria senza ricambio
Il vecchio Toyota, in uno spot pubblicitario, afferma di non comprendere su cosa stanno lavorando giovani tecnici e managers della propria azienda e sorridendo sostiene che ciò è giusto perché altrimenti questi ultimi nulla di nuovo starebbero approntando. Il problema resta. In ultima analisi sono ancora i vecchi capitani d’industria ad avere le leve reali del potere e a concedere maggiore o minora fiducia alle nuove generazioni di dirigenti industriali: la struttura si richiude su se stessa, evidenziando una minore adattabilità all’innovazione di quella più dinamica che si evidenzia in altri paesi in cui l’estrema concorrenzialità tra ceti di managers emergenti miete vittime tra gli individui, ma garantisce un ricambio ad alto livello di imprenditorialità ed una forte flessibilità al cambiamento.
3.4.4 La sfida persa con gli USA
All’inizio degli anni ottanta gli economisti giapponesi (Morita e Ishira) prevedevano nell’arco di un paio di decenni una presa di leadership da parte del proprio paese nei confronti degli Stati Uniti: consideravano già vinta la sfida tecnologica e ne traevano la conseguenza di una successiva primazia nipponica sia economica, che politica e militare. Che ciò non sia avvenuto (cfr. CRAPARO, S., Verso un nuovo Keynesismo, in Comunismo Libertario, a. VII, n. 3, pp. 7-8) appare evidente e le cause di questa sconfitta sono già state delineate: la maggiore flessibilità imprenditoriale statunitense, con le conseguenti dinamiche accelerate nello sviluppo delle produzioni e della finanza da un lato ed il permanere della supremazia tecnologica USA, in cui non hanno giocato un ruolo secondario gli immensi stanziamenti a suo tempo accordati alla ricerca militare nelle cosiddette guerre stellari, (si è ripetuto il fenomeno che negli anni sessanta fu legato alla corsa intrapresa con l’Unione Sovietica per i viaggi spaziali).
4. Clinton II la retromarcia
4.1 Gli avvertimenti
All’inizio del suo mandato Bill Cinton rappresentò, nel panorama di una destra liberista vincente in tutto il mondo, il segno di una possibile inversione di tendenza nello sviluppo capitalistico: uno dei paesi che per primi avevano intrapreso la via friedmaniana, il paese che aveva imposto il proprio credo economico al resto del mondo, sia sviluppato che terzo, grazie alla propria superiore potenza economica, il centro di irradiazione internazionale del neoliberismo monetarista nella sua versione più esasperata (almeno teoricamente), premiava elettoralmente un candidato democratico che non nascondeva di avere tra i suoi grandi ispiratori il Kennedy della Nuova Frontiera ed addirittura il Roosevelt del New Deal. Il programma con cui egli si apprestava ad affrontare il primo mandato era copiosamente condito di interventi sociali, e di un cospicuo rilancio della spesa pubblica, non disgiunto dal ripristino della tassazione progressiva. Alla moglie e musa politica, Hilary, veniva affidato il più ambizioso dei piani di intervento e di risanamento e rilancio dello stato sociale: quello dell’assistenza sanitaria. La reazione dei centri del potere economico è risultata violentissima: scandali di ogni tipo (sessuale, finanziario, politico, ecc.) si sono addensati attorno alla figura del Presidente e hanno condotto, grazie ad una campagna di ottima fattura, alla clamorosa rimonta della destra di Gringrich nelle elezioni di metà mandato nel 1994.
4.2 La resa al capitale finanziario
La pressione cui il capitale finanziario ha sottoposto Clinton è stata vincente, anche grazia al fatto che esso occupava ed occupa tuttora i centri reali della programmazione economica: il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Federale, quest’ultima nella persona del Governatore Greenspan. Egli si è trovato di fronte alla scelta o di mantenere i connotati del proprio programma originario e non venire riconfermato nel 1996, o cambiare rotta sposando le tesi dominanti; su questo secondo asse si è sviluppata la campagna elettorale democratica, che è andata significativamente erodendo nella seconda metà del primo mandato presidenziale il terreno sui cui i repubblicani avevano vinto le elezioni.
4.3 La vittoria nella sfida tecnologica
Nel frattempo gli Stati Uniti avevano visto progressivamente migliorare le prestazioni della propria economia, rispetto alla condizioni disastrose cui si era ridotta nell’ultimo scorcio dell’Amministrazione Reagan e durante quella Bush, anche se quest’ultima aveva già apportato alcuni correttivi alle teorie estreme della scuola di Chicago e mai integralmente queste ultime erano state applicate neppure nel periodo precedente. La vittoria nella sfida tecnologica col Giappone ha consentito agli USA la riconferma di una leadership internazionale ormai traballante alla fine degli anni ottanta e di riconquistare la propria centralità economica, politica e militare; l’ordine con cui nel tempo questi primati sono stati riacquisiti è esattamente rovesciato rispetto all’elencazione fatta. Certo che delle mutazioni irreversibili sono comunque avvenute: il dollaro sta perdendo centralità nel sistema valutario internazionale, il che ripropone uno scenario diverso da quello degli anni cinquanta e sessanta. La divisa statunitense nel 1973 rappresentava il 76,1% delle riserve valutarie mondiali e nel 1995 era scesa al 61,5% (valute europee 14,3% e 20,1% rispettivamente); nel 1980 veniva usata nell’export mondiale per il 56,4%, mentre nel 1992 per il 47,6% (il marco tedesco 13,5% e 15,5% rispettivamente); nelle transazioni giornaliere sui mercati valutari pesava per il 45% nel 1989 e per il 41,5% nel 1996 (il marco tedesco 13,5% e 18,5% rispettivamente); nel 1981 le obbligazioni internazionali erano per il 52,6% in dollari e nel 1995 solo per il 34,2% (valute europee 20,2% e 37,1% rispettivamente); infine nel 1981 i portafogli privati erano costituiti per il 67,3% in dollari e nel 1995 per il 39,8% (valute europee 13,2% e 36,9% rispettivamente). (cfr. Il Sole 24 ore, 12 settembre 1997, p. 6)
4.4 La bilancia commerciale non migliora
Nonostante ciò l’economia statunitense è ancora attraversata da ombre piuttosto rilevanti, che la propaganda tende a non evidenziare. Per fare un esempio, la bilancia commerciale attiva per oltre un secolo e fino alla metà degli anni ottanta, è da allora sprofondata in rosso intenso che non accenna seppur minimamente a cambiare.
Tabella 1
|
Dati* |
interpolazione |
differenza |
|
9.8 |
8.3 |
-1.5 |
|
6.9 |
8.572727 |
1.672727 |
|
8 |
8.845455 |
0.845455 |
|
9.8 |
9.118182 |
-0.68182 |
|
10.9 |
9.290909 |
-1.50909 |
|
8.5 |
9.663636 |
1.163636 |
|
11.9 |
9.936364 |
-1.96364 |
|
10.8 |
10.20909 |
-0.59091 |
|
11.6 |
10.48182 |
-1.11818 |
|
8.1 |
10.75455 |
2.654545 |
|
7.9 |
11.02727 |
3.127273 |
|
12.8 |
11.3 |
-1.5 |
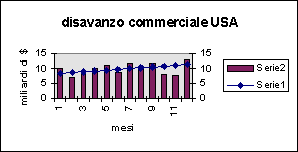 Figura
1
Figura
1
Come si vede dalla seconda colonna della Tabella 1, la retta, riportata in figura 1, che minimizza le distanze dalle oscillazioni, anche forti, presentate dai dati reali del 1996, mostra una crescita costante del disavanzo commerciale statunitense. Ed il peggioramento continua se il disavanzo annuale previsto per il 1997 è superiore a quello del 1996, tendendo ai 113,6 miliardi di $ (cfr. Il Sole 24 ore, 19 settembre 1997, p. 9). Sui presunti successi produttvi e occupazionali ci sarà occasione di ulteriore riflessione.
4.5 Il gendarme non avvolge ad est l'Europa
Una competizione che ha caratterizzato profondamente la storia degli ultimi trent’anni è stata quella tra gli USA e la crescente potenza economica dell’Europa Unita sotto l’egida del marco tedesco: lo scontro tra queste due superpotenze economiche per il controllo di alcune aree di mercato può fornire più di una spiegazione per gli avvenimenti politici, bellici e finanche di cronaca che hanno caratterizzato l’epoca più recente. La corsa per annettersi il promettente mercato degli ex-paesi ad economia pianificata era iniziata ben prima del fatidico crollo del muro di Berlino del 1989. Sia quest’ultimo fatto, sia il dissolversi ed il frantumarsi dell’impero sovietico, sia la deflagrazione di conflitti nella ex Jugoslavia, sono da iscriversi al suo interno. La contiguità territoriale favorisce ovviamente l’Europa e la Germania in particolare, che si sta creando una cintura dilatabile di stati satelliti all’area del marco: Boemia, Ungheria, Slovenia ed in parte Ucraina, Croazia, paesi baltici e Polonia. Per gli USA, fallito il tentativo di sostituire la Francia in Iran (mentre è riuscita l’analoga operazione nel Congo passato da Mobutu a Kabila), per il richiudersi di questo paese nel medioevo sciita, la Bosnia ha rappresentato un’occasione di porre piede sul continente per iniziare a creare un rapporto di continuità territoriale con la Russia, per di più sulla via di deflusso del petrolio caucasico, il cui oleodotto passa non a caso per la Cecenia e la Bosnia. Il controllo dell’operazione militare è stato mantenuto dagli europei, francesi in testa, auspice l’ONU e questo è forse costato il posto a Boutros Ghali. Il tentativo viene riproposto utilizzando la supremazia indiscussa sulla NATO: un pronto allargamento del trattato a tutti i paesi dell’est Europa (come propongono Francia e Italia) è troppo prematuro per la strategia statunitense, che li vede come al momento troppo legati ai paesi dell’UE e rischia inoltre di alterare gli equilibri interni; per di più tenere il controllo degli ingressi, centinandoli, serve a riaffermare, se ce ne fosse bisogno, il dominio USA sull’organizzazione militare.
5.Va in crisi il liberismo?
5.1. Il punto interrogativo nella riga 2.2.
La globalizzazione possiede indubbiamente una sua enorme forza intrinseca. L’apertura di una fase di concorrenza senza limiti, che penetra anche nei segmenti produttivi imponendo la polverizzazione dei cicli produttivi e il ridisegnarsi continuo del network delle correlazioni aziendali, comporta un’estrema mobilità delle produzioni e della forza lavoro (sia fisica, che mentale), con un perenne alternarsi di sviluppo e declino in aree sempre diverse. Il sistema diviene talmente complesso che sfugge a qualsiasi forma di governo: gli equilibri si verificano spontaneamente in zone definite nello spazio e nel tempo, sfuggendo non solo ad ogni programmazione, ma persino ad ogni previsione. Ecco perché diviene cruciale per ogni tentativo di comprensione il punto interrogativo posto nella casella 2.2.6.; ma esso è anche cruciale per la sopravvivenza del sistema, sia nei suoi assetti di potere, sia nelle sue concrete possibilità di sopravvivenza che non possono essere affidate ad equilibri aleatori ed effimeri. Le turbolenze potrebbero susseguirsi ad un ritmo e ad un’intensità insostenibili.
5.2 Anche Friedman pensava all’aggregato monetario
Nelle teorie economiche di questo secolo il problema del controllo del ciclo complessivo non è mai venuto meno. Anche nel neoliberismo monetarista di Milton Friedman esso veniva demandato alla banca centrale. L’intuizione di Keynes che aveva individuato nella moneta e nell’attenta regolazione della sua emissione la chiave di volta del dominio sulla vita economica, in grado di padroneggiare il suo evolversi, si era raffinata, ma era tutt’altro che abbandonata. Dalla moneta tout court si era passato all’aggregato monetario (l’insieme della moneta, dei titoli di stato e di banca, delle obbligazioni, ecc.) chiamato progressivamente M1, M2 ed ora M3 in funzione della sua evoluzione e complicazione. Su questa leva i centri nazionali di emissione potevano e dovevano agire per evitare la transizione del sistema dall’ordine al caos. Ora il mercato globale, la mondializzazione sembrano aprire un’epoca di assoluta deregolazione ignota anche al capitalismo liberale primitivo di Adam Smith, che pure poteva fare affidamento sul controllo doganale: si apre così la via alla turbolenza ingovernabile dell’intero sistema.
5.3 Il libero mercato ha confini tecnologici
La minaccia che la globalizzazione tiene perennemente sospesa sui lavoratori dei paesi industrializzati è quella dello spostamento delle produzioni in aree che offrano maggiori vantaggi economici (costo del lavoro più basso, minori pesi fiscali, minori controlli amministrativi e ambientali, maggiori facilitazioni al licenziamento, ecc.). Di fatto molte fabbriche si stanno spostando in paesi diversi dalla loro originaria collocazione o dall’ubicazione del loro controllo finanziario. Questo fenomeno va però analizzato attentamente, sfuggendo a generalizzazioni banalizzanti, che ne occultino la vera natura. Nel caso italiano, ad esempio, molte imprese calzaturiere hanno decentrato le proprie lavorazioni negli ex paesi ad economia pianificata, di converso la General Electric ha investito denaro nell’acquisto del Nuovo Pignone di Firenze; l’Italia, nonostante sia propagandata come uno dei paesi che offre la maggiore rigidità nel mercato del lavoro (sia per le garanzie che regolano i licenziamenti, sia per l’elevato tasso di sindacalizzazione) è divenuta, in particolare negli ultimi tempi una meta piuttosto frequentata dagli investitori esteri. La Germania, a sua volta sufficientemente rigida nel mercato della forza-lavoro, altamente sindacalizzata e con un costo del lavoro tra i più elevati del mondo, non soffre a tutt’oggi di una crisi degli investimenti. Come si conciliano questi esempi con la mobilità assoluta che il capitale si vanta di possedere? È innegabile che attualmente una delle peculiarità storiche del capitalismo si è ribaltata: un tempo il capitale creava le sue strutture produttivi ed erano i lavoratori a colmare i vuoti nel gioco dell’offerta geografica di lavoro con intensi flussi migratori; d’altra parte la pesantezza dell’apparato produttivo rendeva difficile ogni altra soluzione. Allo stato attuale in cui anche la siderurgia, grazie alle innovazioni tecnologiche, non abbisogna più dei giganteschi altiforni e dei mastodontici impianti ad essi collegati di un tempo, il capitale gode di una mobilità che alla forza lavoro è negata per l’eccesso di offerta che si verifica ovunque, cagione per la quale i flussi migratori che pure si verificano, più che dalla speranza, sono dettati dalla disperazione.
5.4 Si può produrre ovunque ?
In realtà la presunta possibilità del capitale di spostarsi rapidamente in qualunque parte del globo offra condizioni favorevoli agli investimenti, condizioni che nell’immagine giornalistica sono solo quelle relative al basso costo della manodopera, incontra nei fatti seri ostacoli. In primo luogo le produzioni ad alta tecnologia si possono sviluppare laddove il substrato della struttura produttiva è a livello tecnologico appena inferiore: non è in altri termini possibile impiantare un impresa che produca macchine utensili computerizzate in una zona geografica in cui il livello produttivo a tecnologia più elevata sia quello della meccanica di precisione; vi si oppongono i problemi del reperimento della forza-lavoro qualificata e di gran parte dei componenti necessari, la cui veicolazione, nonostante la teoria della concorrenza per fasi di produzione, può risultare eccessivamente costosa a causa dell’ingombro. Tra l’altro non tutta la produzione riguarda le schede elettroniche, di facile trasposto e di produzione in gran parte a basso contenuto tecnologico (produzione e non progettazione). In secondo luogo per essere teatro di una produzione un’area geografica deve contare su adeguate infrastrutture quali: viabilità adeguata, apparati di sicurezza efficienti, formazione del personale adatta, stabilità sociale e politica assicurata, apparato amministrativo malleabile, ma non eccessivamente corrotto, etc.
5.5 Le aree omogenee creano confini
Nel suo saggio La fine dello Stato-nazione (Baldini & Castoldi, Milano 1995) Kenichi Ohmae sostiene la tesi del declino degli aggregati nazionali, in favore dell’affermarsi di aree geografiche omogenee dal punto di vista dello sviluppo economico, viste come più flessibili e dinamiche: è quanto riportato nella quinta colonna della tabella 2. Il teorema è chiaro ed anche vecchio. Nei periodi di rapida mutazione il sistema capitalistico mette in movimento una miriade di imprese che sono la fucina dell’innovazione tecnologica e della sua applicazione alla produzione; poi col tempo il panorama si razionalizza, lasciando in vita solo alcune grosse aziende che capitalizzano lo sforzo dei molti. È successo negli anni settanta a Silicon Valley, all’epoca del boom della produzione dei chip elettronici a semiconduttore, ma è storia di sempre. È evidente che l’intenso sviluppo di poche aree (non a caso Ohmae cita il nord-est italiano) costituisce un motore potente per l’economia internazionale all’epoca del suo mutamento produttivo, costituendo poi, nell’epoca del consolidamento, un costo impressionante dal punto di vista sociale, ma del tutto irrilevante dal punto di vista della gestione economica globale, grazie all’assenza degli investimenti che sono gravati sui singoli che hanno tentato l’avventura. Un conto però è concentrare l’economia di una regione in poche mani, che emergano col tempo come gruppo più o meno monopolistico (ad es. Motorola), un conto è credere che tali aree siano intercambiabili integralmente nel tempo, come auspica la filosofia della mondializzazione. Le strutture che si costituiscono hanno una naturale tendenza ad autoperpetuarsi, cercando dei meccanismi di sopravvivenza e di difesa. Se infatti lo Stato-nazione crea frizione alla propria dissoluzione, per le incrostazioni di interessi che in esso sussistono e trovano la propria ragione di esistenza, ciò avverrà anche per le regioni di sviluppo al momento in cui il loro momento magico venisse a tramontare. L’unica arma prevedibile è quella del sollevarsi di un confine, che funga da barriera alla fuoriuscita della ricchezza ivi prodotta od alla penetrazione degli interessi esterni in grado di modificare gli assetti interni. A lungo andare quindi l’autopoiesi delle aree omogenee, invece di creare un mercato sempre più aperto e globale, rischia di produrre una frammentazione estrema, segmentando a livello feudale la circolazione delle merci.
6. WTO e garanzie sociali
6.1 Verso un nuovo protezionismo?
Il World Trade Organization è l’organismo internazionale che ha sostituito il GATT nel 1996, ovverosia il luogo deputato a regolamentare gli scambi internazionali. Rispetto ai vecchi accordi GATT, il WTO possiede maggiori strumenti coercitivi per rendere operativi i patti sottoscritti e rende quindi meno disperso il potere di controllo sul commercio. Non è un caso che per l’insediamento del direttore del WTO ci sia stato un lungo braccio di ferro tra gli Stati Uniti che sponsorizzavano l’ex Presidente del Messico Salina de Gortari e l’Europa che puntava sull’italiano Renato Ruggiero, che poi ha prevalso sia per gli scandali che hanno coinvolto il candidato statunitense, sia per l’appoggio che su di lui è confluito da parte dei paesi terzi; segno evidente di un tentativo di limitare lo strapotere USA. Il passaggio al nuovo sistema di relazioni commerciali internazionali, dunque, lungamente meditato, risponde ad un’esigenza di controllo su di un settore che la propaganda liberista indica come quello in cui la libertà di movimento dovrebbe divenire, se non lo è già, massimo emblema stesso della globalizzazione dell’economia.
6.2 Lo scontro sulle fibre ottiche
Nell’autunno del 1996 si è tenuta la prima conferenza internazionale del WTO e da essa si possono trarre utili spunti di riflessione. La prima riguarda i limiti alla concorrenza presunta totale che vengono posti in queste assisi. Uno degli scontri, infatti, che ha visti impegnati i paesi convenuti è stato quello tra Stati Uniti ed Europa (Italia in particolare) sulla liberalizzazione o meno degli scambi commerciali delle fibre ottiche; gli Usa, ottenuto l’abbattimento di ogni frontiera doganale sulle telecomunicazioni, settore sotto il loro controllo, hanno opposto una tenace resistenza perché analoghi provvedimenti venissero adottati per il commercio delle fibre ottiche, settore nel quale hanno qualche lunghezza di svantaggio. Hanno vinto la partita solo a metà, ma dal punto di vista del ragionamento che stiamo svolgendo è significativo proprio il fatto che non sia scontato che tutte le barriere doganali cadano come le mura di Gerico al primo squillo della mondializzazione liberista.
6.3 Il WTO ed il dumping sociale
Ancora più interessante è l’altro nodo che ha impegnato a lungo l’assemblea. Non si è giunti ad alcuna conclusione, ma gli Stati Uniti hanno posto il problema: si può lasciare libera concorrenza a quei paesi che producono con condizioni di lavoro impensabili nei paesi di più lunga industrializzazione? In altri termini i paesi dove la manodopera a conquistato livelli di vita e di garanzia sul posto di lavoro che non è ipotizzabile possano essere ridotti (almeno in maniera che non sia estremamente dolorosa) a quelli di certe zone del terzo e del quarto mondo: come convincere un lavoratore tedesco a lavorare in condizioni sanitarie, con salari, con tempi di prestazione paragonabile a quelli di un analogo prestatore d’opera di Singapore? Come pensare di utilizzare negli Stati Uniti il lavoro minorile al di sotto degli otto anni come in Pakistan? E se poi questo fosse possibile quale circolazione monetaria sorreggerebbe il mercato internazionale già asfittico? Allora sorge il problema di garantire la produzione all’interno delle aree economicamente forti e di proteggere la loro produzione dalla concorrenza sleale dei paesi che non offrono adeguate garanzie ai propri lavoratori, praticano cioè una sorta di dumping sociale. Si è cominciato dunque a ragionare sulla possibilità di non commercializzare merci che non diano certezza che la loro produzione sia avvenuta rispettando determinate regole di civiltà. Come detto nulla è stato fatto, ma il fatto che il problema sia stato posto appare molto significativo.
6.4 Barriere doganali si alzeranno anche tra Usa e Europa
Se barriere doganali, dazi, standard di qualità, attestati di garanzie sociali continueranno e interverranno a regolamentare un mercato internazionale sempre più lontano dall’immagine che ne propone la propaganda liberista, ciò risulterà l’inevitabile frutto della guerra commerciale che ha sempre caratterizzato l’evoluzione storica conosciuta. Questa guerra per la conquista dei marcati più appetibili (tra cui spicca la Cina, che sembra avviata finalmente a quello sviluppo a lungo atteso, che ne dispiegherà le enormi potenzialità consumistiche) non potrà non riguardare le due aree maggiormente sviluppate, quello statunitense e quello europeo, comparabili anche dal punto di vista dell’entità (250 milioni di abitanti gli USA, oltre 350 la UE). È difficile non pensare che anche sui loro margini si fermerà la pretesa totale permeabilità dei mercati, come il suaccennato scontro sulle fibre ottiche lascia facilmente supporre. Ne è un esempio ancora più recente l’opposizione europea alla fusione tra Boeing e McDonnell Douglas, che tende a creare un monopolio imbattibile nel settore aerospaziale, sotto il controllo USA. (cfr., Il Sole 24 ore, 18 luglio 1997, p. 1).
7. Il capitale virtuale
7.1 Impedisce ogni programmazione
Gran parte delle operazioni a carattere finanziario non comportano una reale transazione monetaria: si comprano azioni, obbligazioni, valute, merci e si rivendono prima che il corrispettivo pattuito venga corrisposto, grazie al fatto che le scadenze di pagamento sono di vari mesi, tempi ormai lunghissimi in rapporto alle evoluzioni dei mercati internazionali. Tali operazioni sono quindi virtuali, si può cioè investire senza possedere un vero capitale, rivendendo quanto acquistato, prima che si sia chiamati ad onorare: capita spesso che carichi di merci siano più volte acquistate e cedute prima del loro arrivo a destinazione. Le possibilità di operare in modo virtuale è ovviamente cresciuta enormemente con l’informatizzazione dei mercati che amplifica i volumi e le velocità della circolazione finanziaria. C’è anche da ricordare che si prevede che nel 2001 oltre 250 miliardi di ECU di scambi commerciali avverranno tramite i siti Web su Internet: Un futuro senza banche (almeno quelle tradizionali), senza borse (almeno quelle come il New York Stock Exchange), senza carta e, chissà, forse anche senza danaro. (Platero, M., Il boom della finanzia virtuale, in Il sole 24 ore, 8 luglio 1997, p. 7). È evidente che una struttura come quella prospettata risulta incompatibile con qualsiasi forma di controllo e quindi a maggior ragione di programmazione.
7.2 Soffoca il capitale di rischio
Nell’ultimo secolo il capitale finanziario è venuto crescendo d’importanza, fino a divenire, con gli ultimi sviluppi, ipertrofico e totalizzante. La logica con cui esso si muove differisce profondamente da quello dei capitani d’industria su cui si è modellato non solo lo sviluppo capitalistico, ma anche l’alternativa di classe. Il profitto per esso non è il frutto di un investimento lungimirante legato alla produzione di un nuovo bene da immettere nel mercato, oppure ad un’innovazione tecnologica che ne abbassa i costi di produzione, quanto una scommessa a breve termine su fluttuazioni anche temporanee. La sua natura è quindi decisamente speculativa, aliena dai progetti di grande respiro, e se viene dirottato su investimenti produttivi lo fa tramite interposta persona, trasformandosi in usura. Necessita perciò di bassa inflazione e di tassi relativamente elevati, esattamente al contrario del capitale di rischio, che a tali condizioni finisce sotto il suo controllo, perdendo autonomia di manovra.
7.3 Ha il vantaggio di essere impersonale
Ciò che caratterizza nel senso della modernità il capitale finanziario è la sua natura collettiva; quello che conta non è tanto ciò che fa il singolo investitore, anche il più importante e con a disposizione risorse immense come Soros, come un tempo era il grande capitano d’industria che faceva la differenza, quanto gli spostamenti medi che determinano i flussi degli investimenti, spostamenti cui concorrono, ovviamente col loro peso specifico, tutti gli investitori, anche i più piccoli. Può sembrare che così la forma sociale capitalistica vada sfumando in una polverizzazione che renda evanescente l’avversario di classe. È però per l’appunto il peso specifico dei singoli investitori che rende poi particolarmente significativi i movimenti delle grosse finanziarie, che poi sono quelle che raccolgono e gestiscono nella realtà i piccoli capitali dei minori, che partecipano al banchetto virtualmente, soprattutto per ciò che riguarda il potere decisionale e di individuazione delle linea strategica.
7.4 Solo speculazione
Un capitale la cui unica prospettiva è quella del profitto a breve termine, non seleziona i propri obiettivi, dirigendosi indifferentemente sul cambio delle valute, sulle azioni che promettono incrementi rilevanti in tempi brevi, sugli investimenti edilizi nelle aree di nuova urbanizzazione, etc. Le conseguenze di ciò sono molteplici. In primo luogo la produzione nazionale diviene un concetto irrilevante, motivo per cui gli Stati Uniti sono andati incontro negli anni ottanta ad un violento processo di deindustrializzazione. In secondo luogo la conoscenza delle scelte dei governi e dei centri economici diviene sempre più importante e sostituisce il fiuto per il mercato che contraddistingueva l’imprenditoria industriale fino al secondo dopoguerra, con il conseguente dilagare della corruzione, che ne diviene il necessario corollario.
7.5 Possibili strumenti di controllo
Le contraddizioni insite nell’ipertrofia del capitale finanziario, nel suo aspetto più inquietante di capitale virtuale, tendono a divenire dirompenti per l’assetto complessivo del sistema. Il respiro corto che gli è proprio impedisce ogni forma di programmazione strategica. La sua propensione alle forme speculative, tende a rendere eccessivamente gravoso l’investimento produttivo (elevati tassi di interesse, accelerazione dei processi di deindustrializzazione in presenza di momenti di stagnazione, bassi livelli inflattivi per garantire le banche erogatrici dei prestiti). Soprattutto temibile per la struttura economica è la fluttuazione incontrollabile che crea e distrugge imperi finanziari, cui non corrisponde una solida base di capitale. Appare quindi necessario intervenire con forme di regolamentazione che rendano meno dirompenti gli aspetti estremi della speculazione virtuale. Sono pensabili forme di controllo? È la stessa tecnologia informatica, potente leva del problema, a suggerire soluzioni. Ad esempio, è possibile ipotizzare delle interruzioni casuali delle contrattazioni con contemporanea imposizione di onorare gli impegni esistenti al momento: si tratta cioè di fare un’istantanea del mercato non programmata né programmabile, ma gestita del tutto casualmente da un sistema computerizzato. Ciò renderebbe estremamente rischiose le operazioni puramente speculative che sono all’origine di molte avventure finanziarie.
8. Verso Maastricht?
Solo nel 1996 l’Italia veniva presentata come il fanalino di coda dell’UE, con possibilità solo retoriche di entrare nel sistema dell’Euro. Nell’estate 1997 tutti i paesi presentano divergenze nei confronti dei parametri a suo tempo fissati nel Trattato di Maastricht (Germania compresa) e l’Italia viene promossa tra i primi della classe, seconda forse al solo Lussemburgo. Nel vertice di Amsterdam il treno avviato verso la moneta unica è stato parcheggiato su di un binario la cui destinazione è molto meno chiara. Occorre analizzare cosa è successo nell’ultimo decennio per capire la battuta di arresto che l’Europa dei banchieri ha subito.
8.1 C'erano le destre al potere, oggi ci sono le sinistre
Al momento della ratifica del trattato, la destra già saldamente insediata da tempo al potere in Gran Bretagna, aveva usufruito di una straordinaria stagione elettorale nella maggioranza dei paesi europei e con essa il credo monetarista si era affermato senza ostacoli. Le fortune elettorali sembrano aver recentemente cambiato direzione ed è la sinistra che governa nella maggioranza dei paesi dell’UE (escluse la Spagna e la Germania per il momento), o da sola o in governi di coalizione.
8.2 La politica economica sembra non mutare
Nonostante tale mutamento del quadro politico, l’indirizzo economico di stampo monetarista appare largamente predominante. Alcune forze riformiste, o comunque legate tradizionalmente ad impostazioni economiche keynesiane o neokeynesiane, sono giunte al potere mutuando temi tradizionali delle forze conservatrici: è il caso del secondo mandato presidenziale di Clinton, come abbiamo già detto, della vittoria laburista di Blair in Gran Bretagna, e della conversione tutta neoliberista della forza egemone della coalizione dell’Ulivo in Italia, il PDS. Altre stanno scontando una lenta mutazione dal momento del loro avvento al potere: Jospin in Francia e il PASOK in Grecia dopo la morte di Papandreu. Sembra quindi inevitabile che, per motivi immanenti all’evoluzione della struttura economica o per ragioni di egemonia politica delle forze legate al capitale finanziario, che le ricette dettate dalla teoria economica dominante finiscano per piegare al proprio volere chiunque si trovi a governare, indipendentemente dal punto di partenza della propria parabola evolutiva.
8.3 Ma lo spostamento elettorale è comunque significativo
Rimane un dato su cui riflettere: l’insuccesso elettorale dei governi che adottano inflessibili rimedi monetaristi alla congiuntura economica. Gli esperimenti felici di Reagan e della Thatcher, compiuti in epoche in cui gli effetti di questi rimedi non erano ancora evidenti, si sono ormai conclusi. Interessante è anche il fatto che non è solo la destra a pagare elettoralmente le scelte neoliberiste, ma anche i governi di sinistra hanno subito pesanti sconfitte: Gonzales un Spagna, Mitterand in Francia e lo stesso Berlusconi vinse le elezioni del 1994 in Italia su di un programma vagamente neokeynesiano (un milione di posti di lavoro) ed in opposizione ad una sinistra che aveva appoggiato i governi Amato e Ciampi. La profonda dicotomia che l’applicazione delle teorie friedmaniane genera nella società crea una massa crescente di scontenti, che oscillano elettoralmente permanendo all’opposizione, mentre nello stesso tempo erode la consistenza dei ceti medi, tradizionale bacino elettorale del riformismo classico.
8.4 La lobby monetarista detiene ancora le leve finanziarie
Uno di problemi per cui impostare una politica economica divergente rispetto ai parametri attualmente vigenti è estremamente difficile e necessita dello sforzo coordinato di più di un paese, fosse esso gli Stati Uniti, è che i centri della programmazione economica di livello internazionale, quali il Fondo Monetario Internazionale (FMI) sono sotto il saldo controllo degli economisti di impostazione rigidamente monetarista. Tale controllo ha permesso negli anni passati l’innesto di politiche neoliberiste anche nei paesi del terzo mondo che, gravati da debiti enormi nei confronti del sistema bancario internazionale, e del FMI in particolare, hanno dovuto subire il ricatto dell’adozione delle misure che a detta degli operatori garantivano i loro crediti, per potersi vedere dilazionare i pagamenti o rinnovare i prestiti. (Tra l’altro "l’intrusione dei sindacati del crimine è stata facilitata dai programmi di aggiustamento strutturale imposti ai paesi indebitati dal FMI per accedere a nuovi prestiti", in United Nations, La globalisation du crime, New York 1955). Sono altresì sotto stretto controllo monetarista le banche centrali dei principali paesi industrializzati, legate, come è ovvio, agli interessi del capitale finanziario. Rimuovere questa incrostazione di potere, per di più forte dell’appoggio della finanza internazionale, è impresa di non piccolo respiro.
8.5 Ma la Germania è solo Buba?
Senza dubbio la Germania ha rappresentato e rappresenta il paese egemone dell’UE, tanto da far pensare che sul suo modello si costruisse l’integrazione europea, di modo che esso divenisse un letto di Procuste per gli altri membri. Di fatto l’area del marco è estremamente vasta e gode di una notevole solidità produttiva. D’altro lato la struttura produttiva tedesca gode di alcune significative peculiarità: forte integrazione tra capitale finanziario e capitale di rischio, robusto sistema di garanzie sociali, coniugazione di alti livelli salariali e bilancia commerciale in attivo, crescita costante del PIL e alta propensione all’investimento estero. Se la Bundesbank (Buba per gli amici) è uno dei templi del monetarismo, ciò non ha ancora toccato profondamente lo stato sociale. Nonostante tutto ciò è ormai certo che neppure la Germania centrerà il parametro del 3% di rapporto tra deficit pubblico e PIL previsto dal trattato di Maastricht, ed il penoso tentativo di barare sui conti rivalutando le riserve auree, vanificato dalla rigida opposizione di Tietmeyer, ne è una lampante verifica. Se il vertice della Banca Federale, nel suo rigore neoliberista, difende la purezza del trattato da essa ispirato, nella convinzione che l’Europa monetaria o nasce su basi di assoluto rigore o è meglio subisca un rinvio, finendo così per rappresentare un ostacolo ad un accordo politico realistico, gran parte dell’opinione pubblica tedesca (oltre il 60%) è contraria all’integrazione, facendo così della stessa Germania un anello debole della nascitura UE e costellando di spine l’ultimo anno di mandato del longevo cancelliere Kohl. In realtà non è tanto, come si legge sui giornali, che i tedeschi temano la moneta unica in quanto essa sarebbe debole per la commistione del marco con monete derelitte quali la lira; il problema è che al fine, dopo anni, anche nel paese più industrializzato dell’Europa, il rigore monetarista inizia a mordere, riducendo garanzie sociali e salari. D’altra parte l’insistenza del governo per centrare l’obiettivo del 1999 si spiega col desiderio dell’imprenditoria tedesca di imbrigliare definitivamente la sleale concorrenza dell’Italia in particolare sui mercati esteri, giocata fino a questa estate sulle manovre di deprezzamento della moneta nazionale, che ha pesato particolarmente in un momento, l’ultimo lustro, in cui gran parte delle risorse interne erano dedicate con priorità alla costosa integrazione dei Länder dell’ex DDR. La diversità di opinione tra il governo federale e il vertice della Banca centrale è emersa ancora clamorosamente all’inizio di settembre (cfr. Il Sole 24 ore, 4 settembre 1997, p.1 e p.7).
8.6 La Francia tra recessione e colonizzazione
Ancora più stretta è la via che deve percorrere la Francia, dopo la vittoria socialista nelle elezioni anticipate. Sfuggita all’abbraccio soffocante col marco, cui l’aveva costretta il governo Juppé-Chirac nell’illusione di un asse paritario per la leadership continentale, che si sarebbe inevitabilmente tradotto in una forma di subordinazione coloniale, il paese deve affrontare rilevanti problemi economici. Infatti l’eredità della politica del franco forte è molto pesante, essendosi tradotta in una secca perdita di competitività delle merci francesi, non compensata da un’offerta di qualità paragonabile a quella tedesca. La crisi delle esportazioni comporta una fase recessiva, con la chiusura di molte aziende, anche storiche, che contribuisce a deprimere la congiuntura. Non è un caso che il governo Jospin abbia messo in agenda come prioritario il tema dell’occupazione, dato che la Francia vanta un tasso di disoccupazione superiore a quello italiano, e che si opponga a proseguire la politica di privatizzazioni (crisi del vertice Air France, cfr. Il Sole 24 ore, 4 settembre 1997, p. 34). I vincoli della politica economica internazionale limitano il raggio potenzialmente innovativo del nuovo gruppo dirigente francese, non supportato da analoghe tendenze in altri paesi, e già si avvertono segnali di mesti ripiegamenti su sentieri consueti, privi di sbocchi propulsivi per l’economia reale (cfr. Il Sole 24 ore, 17 settembre 1997, p.6).
8.7 La Gran Bretagna per la tangente laburista
Il paese che, tra quelli industrializzati, ha imboccato per primo il sentiero neoliberista, ha dopo quasi 20 anni voltato parzialmente pagina. È legittimo chiedersi i risultati di questa lunga cura. Prima di tutto un dato generale: la Gran Bretagna è scesa di un posto, dal quarto al quinto, nella classifica dei paesi più industrializzati, graduati in base al PIL, sopravanzata dall’Italia. Vediamo il dettaglio. Dal 1979 al 1994 "la crescita del pil pro capite britannico è stata maggiore rispetto a USA, Francia e Canada, uguale alla Germania e inferiore solo a Italia e Giappone [ ... ] la produttività è cresciuta a ritmo doppio rispetto a USA, Germania e Svezia, è stata del 30% superiore alla Francia e inferiore a Italia e Giappone [ ... ] calavano da 13 a 7,3 milioni i lavoratori sindacalizzati [ ... ] agli attuali disoccupati (1,7 milioni pari al 6,2% della popolazione attiva) vanno aggiunti quasi 3 milioni di persone, tagliate fuori dalla vita economica e ormai assenti dalle liste di chi cerca lavoro. [per un complesso del 17,4% (ndr)] La cifra pare esagerata. Andrew Cates [ ... ] stima in 500mila unità i disoccupati occulti, con un totale di 2,2 milioni di disoccupati reali, pari a un tasso del 7,9%. [ ... ] tutta la popolazione ha registrato un forte aumento dei redditi in questi diciott’anni. Certo il 10% più ricco li ha visti aumentare del 60%, mentre il 10% più povero (solo caso di reale regresso li ha visti calare del 13%. [ ... ] Con una spesa pubblica scesa modestamente (dal 44 al 41% del pil dal 1979), spesa sociale e sanitaria sono salite nel periodo da un terzo a metà del totale." (fonte: Il sole 24 ore, 25 marzo 1997, p.4 ) Queste cifre parlano da sole. Due soli commenti: l’indeterminatezza sul tasso reale di disoccupazione, su cui sarà opportuno soffermarsi in seguito, e il crescente divario tra ricchi e poveri. Dal punto di vista politico la vittoria di Blair è segnata da un abbandono totale dei temi keynesiani cari al labour tradizionale, con l’assunzione di impostazioni tipiche dei conservatori, ma è pur sempre frutto della crescente insoddisfazione che la lungamente perseguita politica economia monetarista aveva seminato, come dimostra l’inesorabile e patetico declino del governo Major. D’altra parte essa segna un profondo distacco dall’orizzonte europeo, che sta già mostrando i suoi frutti.
8.8 Sfuma il debole fronte economico europeo nel WTO
La fragile alleanza europea, che si era contrapposta agli USA nel WTO di inizio anno, si sbriciola sotto le spinte degli interessi contrapposti e centrifughi. Si è visto con chiarezza nella vicenda della riforma del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, che ha trovato su sponde diverse la Francia già membro di diritto del Consiglio, la Germania desiderosa di vedere riconosciuta nella politica internazionale il proprio ruolo di potenza economica di prim’ordine e l’Italia in cerca di un proprio ruolo autonomo come mediatrice tra paesi industrializzati e paesi dl terzo mondo. La moneta unica diviene sempre più un obiettivo mitico, al di là dell’ottimismo di facciata. Pura mossa politica, volta a contenere le spinte centrifughe emergenti, è stata, ad esempio, la decisione dei ministri economici dei 15 paesi dell’UE del 13 settembre 1997 di anticipare l’applicazione di cambi fissi tra le varie monete nazionali al maggio 1998, prima cioè della scadenza ufficiale per la creazione dell’Euro, prevista per il gennaio 1999. La tenacia con cui questo fantasma (a proposito dei parametri di convergenza [deficit/Pil 3%, indebitamento/Pil 60%, inflazione 2,5%] si noti che il Giappone ha un deficit del 5-6% e un indebitamento pari al 120% [cfr Il Sole 24 ore, 8 ottobre 1997, p. 7) viene sorretto nonostante tutto risponde a due esigenze: la prima è che esso corrisponde ancora a degli interessi reali (la grande finanza europea, le banche centrali, le borghesie imprenditoriali penalizzate dalla concorrenza sleale sul valore della moneta); la seconda è che esso è stato e continua ad essere un utile paravento per giustificare all’interno dei singoli paesi politiche di smantellamento delle garanzie sociali esistenti il cui fine più che economico è eminentemente politico: indebolire e frazionare il movimento dei lavoratori. Per convincersi di quest’ultima asserzione basta andarsi a rivedere nel § 8.7. quanto riportato sui dati della sindacalizzazione in Gran Bretagna dal 1979 al 1994.
9. Il caso italiano (ossia, ma che bella svalutazione!)
Nel 1992, nel pieno di una grave crisi economica, il capitale italiano sceglieva la via unilaterale della svalutazione della moneta, per rendere concorrenzialità alle merci italiane sui mercati internazionali. L’operazione è terminata nel 1996 con una svalutazione complessiva di oltre il 30%. (Figura 2)
Figura 2
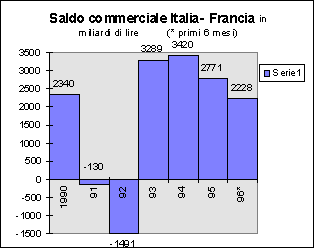
Gli effetti espansivi, legati alla crescita delle esportazioni, risultano evidenti dal grafico riportato nella Figura 3.
Figura 3

Ciò ha creato seri problemi ai presunti partners dell’UE. Ne è un esempio palese l’andamento della bilancia commerciale con la Francia riportato in figura 4.
Figura 4
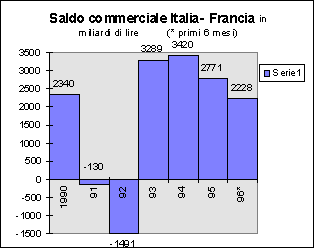
da Il sole 24 ore , 10 dicembre 1996
Il rientro nello SME ha chiuso questo felice periodo (nei primi otto mesi del 1997 l’attivo commerciale è stato ancora rilevante, pari a 30.368 miliardi, ma in calo rispetto al 1996, con una crescita rilevante delle importazioni rispetto a quella delle esportazioni, in relazioni anche alla crescita produttiva [cfr. Il Sole 24 ore, 8 ottobre 1997, p. 9]), mettendo l’imprenditoria italiana di fronte ai frutti della propria scelta: la spinta verso un modello esportativo ha depresso sensibilmente il mercato interno, soffocato dalla compressione salariale e dal rientro nel bilancio privato dei servizi un tempo offerti dallo stato sociale. Il rimedio, temporaneo, è stato quello di incentivare il mercato dell’auto, offrendo un finanziamento statale a fondo perduto per coloro che acquistavano un auto nuova restituendo la vecchia. Così la crescita della vendita del settore è stata nei primi otto mesi del 1997 del 34,9% (cfr. Il Sole 24 ore, 11 settembre 1997, p. 9). I motivi della privilegio accordato alla produzione automobilistica sono plurimi: il peso rilevante che essa ha nell’economia nazionale con il conseguente peso politico, la crisi che essa attraversava a fine dello scorso anno, la convinzione che essa potesse fungere da volano per l’intera economia. Gli effetti di ripresina che questa manovra ha indotta sono alla base delle trionfali dichiarazioni di Governo e Confindustria, ma essa è di corto respiro.
Tabella 2
I conti delle pubbliche amministrazioni (dati in miliardi di lire) fonte: Relazione di cassa 1997
|
1996 |
1997 |
var. % |
|
| USCITE | |||
| consumi collettivi |
306350 |
315752 |
3,069039 |
| Interessi passivi |
201990 |
190052 |
-5,91019 |
| Contributi alla produzione |
28780 |
21348 |
-25,8235 |
| Prestazioni sociali |
360820 |
386083 |
7,001552 |
| Altre uscite correnti |
23330 |
25940 |
11,18731 |
| Totale uscite correnti |
921270 |
939175 |
1,943513 |
| Totale uscite conto capitale |
74400 |
62871 |
-15,496 |
| TOTALE USCITE COMPLESSIVE |
995670 |
1002046 |
0,640373 |
| ENTRATE |
|
|
|
| Entrate tributarie |
507490 |
550479 |
8,470906 |
| Contributi sociali |
282170 |
299859 |
6,268916 |
| Altre entrate correnti |
70910 |
72340 |
2,016641 |
| Totale entrate correnti |
860570 |
922678 |
7,217077 |
| TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE |
869170 |
927745 |
6,739188 |
| Disavanzo corrente |
-60700 |
-16497 |
-72,8221 |
| Indebitamento netto |
-126500 |
-74301 |
-41,264 |
| in % del PIL |
-6,75257 |
-3,80251 |
|
| Avanzo primario |
75490 |
115751 |
53,33289 |
| in % del PIL |
4,029656 |
5,923794 |
|
| PIL (valore nominale) | 1873361 | 1954001 | 4,304563 |
Fonte Il sole 24 ore 22.03.1997, p. 4
Se manca una strategia di sviluppo che possa generare effetti positivi duraturi, il lungo impegno a risanare i conti pubblici è giunto ad una svolta significativa, come si vede dalla tabella 2. È forse superfluo osservare che i costi dell’operazione sono gravati esclusivamente sul lavoro dipendente.
10. Conclusioni (?)
10.1 Passaggio stretto tra un capitalismo con i capitalisti e un capitalismo acefalo
È tramontato il mondo dei grandi capitani d’industria, delle grandi famiglie borghesi, della concorrenza temperata dagli accordi internazionali, dalle associazioni in cui si definiva la strategia globale (Trilateral, Bilderberg, etc.). Il personaggio emblematico del momento è il finanziere Soros ed il suo apparente fiuto infallibile (anche su negli ultimi tempi non appare più tale) per gli affari buoni. Ma questo mutamento di pelle, nei suoi aspetti innovativi, ha riflessi sociale fortemente regressivi, prefigurando un sistema di rapporti di produzioni degno della prima rivoluzione industriale. Ma la strada del cambiamento è più accidentata del previsto; in particolare l’esasperazione dell’aspetto concorrenziale in assenza di qualsiasi regola impedisce una programmazione strategica e ciò appare essere un tallone d’Achille per la sopravvivenza stessa del sistema, accentuandone le contraddizioni interne. In altre parole, senza un comando strategico il libero sviluppo delle spinte del mercato abbandonate a se stesse può provocare l’implosione del sistema, come già nella seconda metà del secolo scorso il liberismo, pur temperato dalle barriere doganali, aveva creato un collo di bottiglia allo sviluppo del sistema, superato solo negli anni trenta del novecento con una radicale revisione dell’impostazione teorica della macroeconomia. Analizziamo i punti essenziali che generano contraddizioni insanabili nel sistema neoliberista del mercato globale.
10.2 La regionalizzazione segmenta il mercato che la crea
Il primo aspetto da non sottovalutare è quello relativo alla spinta alla segmentazione, che viene evidenziandosi nell’ultimo decennio. La globalizzazione, invece di ridurre le frontiere, sostituisce alle nazioni, nel loro impianto ottocentesco, le regioni omogenee economicamente e lo sviluppo diseguale parcellizza il territorio in maglie strette. Il risultato evidente è la continua nascita di nuovi aggregati statali che frazionano anche il mercato (cfr, MARCOS, 7 pezzi sparsi del rompicapo mondiale, http://www.tmcrew.org/chiapas/rompicap.htm, p. 9). Ma spinte alla nascita di nuove forme di protezionismo di fronte alla concorrenza selvaggia e distruttrice emergono anche nelle uniche assisi per la regolamentazione del commercio a livello internazionale sopravvissute (cfr. il § 6). La tendenza alla costruzione di un mercato globale, dominante, anzi travolgente, fino ad ora, vede sorgere una controtendenza, che sta acquistando vigore.
10.3 Non si controlla il conflitto economico né quello sociale
La mancanza di ogni possibilità di controllo della guerra concorrenziale nel campo economica, già accennata nel § 7.1 ed evidenziata nella riga 2.2., è solo uno degli aspetti di incontenibile conflittualità che l’assetto neoliberista genera. La crescente divaricazione tra ceti ricchi e ceti poveri esaspera il conflitto, anche se esso non assume le forme di classe, ma quello dell’allargamento della criminalità o di esplosioni violente, ma circoscritte e senza chiare finalità. La via scelta per contenere tale fattore di endemica instabilità sociale è quello della pura e semplice repressione: non è un caso che l’unica struttura che nasce accanto alla Banca centrale europea, nel trattato di Maastricht, è l’esercito dell’Unione. Negli Stati Uniti , dove i processi sono temporalmente più avanzati, il problema, studiato nei suoi effetti e nella sua portata nel black-out di New York, ha prodotto la creazione di zone urbane ormai fuori dal controllo e quindi governate da bande in perenne conflitto tra di loro, intransitabili per i non residenti e di conseguenza abbandonate al più totale degrado. I ceti abbienti tendono a rinchiudersi, di converso, in zone recintate e presidiate da un ingente esercito di guardie private e dotate di sofisticati sistemi di sicurezza: residenze dorate e blindate. Tale bipartizione è ormai tipica di tutte le capitali del terzo mondo, in cui solo il quartiere residenziale funge da rifugio delle ricchissime borghesie nazionali, mentre il restante territorio urbano resta terreno di conquista della grande e piccola criminalità diffusa e organizzata. La situazione non rappresenta però soltanto uno spiacevole effetto secondario sul piano sociale della struttura economica, ma tende a divenire anche un costo crescente via via meno sostenibile, con la crescita ipertrofica degli apparati di sicurezza la cui spesa è tipicamente improduttiva.
10.4 Il mercato non chiude il ciclo
Il problema cardine del nuovo assetto globale dell’economia viene dall’eterno problema del capitalismo: il mercato. Croce del liberismo classico col suo succedersi di cicli ravvicinati di cicli, ossessione del marginalismo, volano interno al sistema macroeconomico keynesiano crollato sul ruolo del capitale finanziario, il mercato rimane la grande incognita del neoliberismo. La costante compressione del potere complessivo d’acquisto nei paesi industrializzati, con l’allargamento costante dei ceti indigenti e la riduzione dei servizi sociali che sposta risorse dai beni alla finanza, e la persistente e crescente depauperazione dei paesi terzi e quarti fungono da fattori di restringimento dei mercati mondiali nel loro complesso, creando un permanete collo di bottiglia sia al mercato dei beni di consumo, sia, di conseguenza, a quello dei beni durevoli, e tenendo basso il tenore dell’economia complessiva. Ciò spiega il perenne alternarsi di ripresine di corto respiro e di stagnazioni e pone una pesante ipoteca sulle politiche volte a creare modelli produttivi puramente esportativi.
10.5 Il paradosso della concorrenza illimitata
Tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre Il Sole 24 ore è stato teatro di un interessante dibattito sui limiti della concorrenza, che ha coinvolto vari economisti, echeggiando analoghi dibattiti già sviluppati in altri paesi. Se ne ricava una contraddizione insanabile all’interno del sistema neoliberista. Questa la sua enunciazione: se non si pongono regole alla concorrenza, in un tempo più o meno lungo i gruppi economicamente più forti assorbono o distruggono quelli più deboli, tendendo naturalmente a riprodurre il mercato monopolistico o oligopolistico; se si pongono regole il mercato non è più libero e sorge subito il problema su chi pone le regole e quali esse siano. In ogni modo il libero mercato è un’utopia negativa e, se si applica la liberalizzazione integrale, proprio il mercato fagocita sé stesso.
10.6 Tre miti massmediologici
I mass media, perennemente impegnati nell’opera di spandere ottimismo su le magnifiche sorti e progressive (MAMIANI, Terenzio, Inni sacri. Dedica, 1832) del moderno assetto globale, puntano su tre aspetti dell’andamento economico planetario che dovrebbero rendere giustizia alla strada imboccata, i cui benefici frutti si devono inevitabilmente presentare. Come vedremo questi tre aspetti si rivelano dei veri e propri miti contemporanei.
10.6.1 La ripresa
Per definizione la ripresa è quella cosa perennemente dietro l’angolo. Ad esempio la buona congiuntura che pare attraversare nel settembre del 1997 l’Italia e che fa da supporto al trionfalismo governativo, si dice che sia molto promettente, ma fragile e da consolidare, il che ovviamente consiglia di proseguire, anzi di marcare ulteriormente la linea di politica economica perseguita. È forse un caso, ma quando nel panorama internazionale un area produttiva accenna ad accelerare il passo, un’altra perde i colpi di modo che nel complesso tutto il sistema globale finisce per ingolfarsi. Sempre nel settembre del 1997 le economia dell’Europa e degli USA paiono accennare ad un timido rilancio, ecco che il Giappone e persino le tigri asiatiche (Thailandia in testa) iniziano ad ansimare, smorzando l’euforia degli economisti (cfr. Il Sole 24 ore, 18 settembre 1997, p. 3 e 19 settembre 1997, p.7). In sostanza c’è sempre qualcuno che rovina la festa che dovrebbe segnare il trionfo delle teorie della mano libera al mercato e che rinvia il momento in cui i sacrifici sopportati in tutto il mondo dalle masse sfruttate portino i frutti promessi. La ripresa, quella vera, non ci sarà perché il sistema tende ad avvitarsi su se stesso per la continua contrazione che il mercato complessivo tende a subire, a causa delle politiche restrittive adottate dovunque.
La disoccupazione cresce in tutto il mondo. Il rimedio è semplicissimo, a sentire industriali ed economisti: più si rende flessibile il mercato del lavoro (il che significa abolire ogni garanzia sulle modalità di prestazione d’opera, mano libera agli imprenditori sui licenziamenti, sostanziale morte della contrattazione collettiva), più cresce l’occupazione; Regno Unito e Stati Uniti, con i loro bassi tassi di disoccupazione, sono la dimostrazione della bontà della proposta. Il caso reale della Gran Bretagna è ben descritto nel brano riportato nel § 8.7, ma lo stesso ragionamento vale per gli USA. Perché tanta differenza tra dati ufficiali e dati reali? Dipende dal sistema di calcolo, profondamente diverso da quello in uso negli altri paesi europei: si esce dal computo dei disoccupati, se per un certo periodo, scoraggiati, si interrompe la ricerca di un lavoro, oppure se si lavora anche alcuni giorni in un anno. Il miracolo della crescente occupazione nei paesi anglosassoni sta tutto in questi trucchi contabili e nel continuo crearsi di lavori a termine, sottopagati e relativi a servizi marginali, quali quelli della ristorazione. D’altra parte che la flessibilità non crea lavoro stabile è dimostrato dalla Francia che con un indice di deregolamentazione del mercato del lavoro doppio a quello dell’Italia, soffre di un tasso di disoccupazione superiore, anche se di poco (12,3% contro 12,1%). Addirittura, recentemente la Confindustria ha sostenuto che un maggiore orario di lavoro favorisce l’occupazione, con il capzioso ragionamento per il quale maggiore lavoro crea maggiore sviluppo e quindi più opportunità di lavoro; il quotidiano dei padroni ha pubblicato i dati che avrebbero dovuto dimostrare quanto affermato, ma facendo pari a 100 la media dell’orario annuo di lavoro e del tasso di disoccupazione la correlazione tra i due parametri pare molto discutibile (vedi Figura 5).
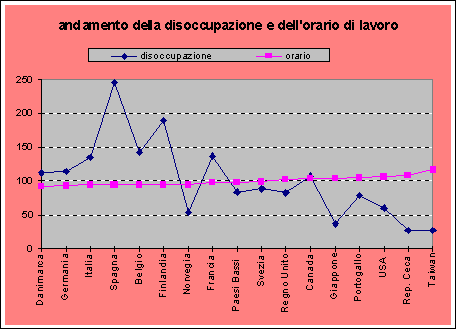
Fonte: nostra elaborazione su dati de Il Sole 24 ore media = 100
La correlazione non vale, ovviamente, neanche in senso inverso: minore orario di per sé non è sinonimo di aumento dell’occupazione. Nel numero del 1 ottobre 1997 a p. 3 Il Sole 24 ore ci ha riprovato, pubblicando un diagramma relativo a dieci paesi in cui erano riportati i tassi di disoccupazione insieme alle medie annue dell’orario di lavoro. Il titolo era molto significativo: Più ore, più occupati. A parte il fatto che i tassi di disoccupazione erano variati rispetto a quelli forniti nemmeno un mese prima, a riprova della loro aleatorietà, ancora una volta un semplice calcolo fornisce immediatamente l’assenza di una correlazione significativa tra le due serie di date. Resta il fatto che il fenomeno della disoccupazione risente di troppi fattori per permettere di individuare un unico parametro cui esso possa rispondere. Vanno considerati, oltre all’orario di lavoro, il prodotto interno lordo, il grado d’innovazione tecnologica, il tasso di crescita dell’economia, la propensione all’investimento, la quantità e la qualità dei servizi sociali, le spese improduttive dello Stato, il salario medio e la conseguente propensione al doppio lavoro a nero, la percentuale di economia sommersa con il tasso di immigrazione, i trattamenti pensionistici, l’entità della popolazione attiva o considerata tale nelle statistiche ufficiali.
10.6.3 La previdenza
La diversità dei regimi pensionistici esistenti nei vari paesi, frutto di storie profondamente diverse, non permette, nei limiti del presente documento, un’analisi approfondita è comparata di essi. Queste brevi considerazioni riguarderanno, pertanto, la previdenza italiana, su cui per altro si appuntano le attenzioni del FMI e che appare essere ormai l’unico ostacolo al luminoso traguardo dell’ingresso in Europa, ormai a portata di mano. Orsono meno di due anni che i trattamenti pensionistici hanno subito in Italia una drastica cura dimagrante, il cui frutto immediato è stato una rottura generazionale tra chi vantava al dicembre 1995 meno di 18 anni di contributi e chi di più, i cui frutti di risparmio hanno iniziato a manifestarsi nel 1997 e i cui frutti di politica economica sono ormai ineluttabili con lo spostamento di risorse di denaro al capitale privato per le pensioni integrative. A ciò va aggiunto che la spesa previdenziale prevista dalla riforma Dini, già comprensiva di notevoli risparmi, è a tutt’oggi sostanzialmente rispettata (un netto risparmio nel 1996 ed un pari aggravio nel 1997, soprattutto a causa dell’esodo nel pubblico impiego, scuola in particolare, provocato dal susseguirsi di voci allarmistiche, proclami della Confindustria e dichiarazioni governative). Le proiezioni per il 1998 indicano ancora un risparmio rispetto alle previsioni della riforma. Nel primo triennio di applicazione, quindi, il sistema pensionistico costerà addirittura meno del previsto. Perché allora tanto accanimento, una così intensa e martellante propaganda? Se gli effetti economici sono ormai in fase di concretizzazione per il sistema finanziario, se gli effetti sul risparmio della pubblica amministrazione sono già operanti, che scopi si prefigge questo nuovo pesante attacco al sistema pensionistico? La risposta è parallela a quella che spiega gli altri due miti dei mass media italiani.
10.6.4 Sono funzionali alla divisione della classe
L’Italia è il paese che più drasticamente ha ridotto il proprio deficit nel corso degli ultimi cinque anni, tanto che paradossalmente pare essersi invertito il ruolo con la Germania per il rispetto dei parametri del trattato di Maastricht. Permane il grosso problema del debito pubblico, che vede il paese con il 122% del PIL secondo soltanto al Belgio (127%) nella classifica dell’indebitamento dello Stato; ma anche in questo caso la tendenza all’aumento si è invertita nel 1996 e nel 1997 anche la spesa per gli interessi sui debiti accumulati ha iniziato a diminuire. D’altra parte il disavanzo, uno dei parametri da considerare per la convergenza verso la moneta unica, vede fuori norma 11 dei 15 paesi (sono in regola solo la Finlandia con il 59,4%, la Francia con il 57,2%, il Regno Unito con il 55,2% ed il Lussemburgo con il 6,5% [previsioni Eurostat per il 1997, ne Il Sole 24 ore, 25 settembre 1997, p. 7]). Ne consegue che l’ulteriore attacco al sistema pensionistico ha principalmente fini politici, gli stessi fini che giustificano l’insistenza sull’imminente ripresa e sulla richiesta della mano libera all’imprenditoria sulle assunzioni per consentire nuove occasioni di impiego: presentare i lavoratori dipendenti come portatori di interessi singoli e non collettivi di fronte alla prestazione d’opera. Deve rompersi ogni rapporto solidale tra occupati e disoccupati, tra lavoratori attivi e lavoratori in quiescienza; è necessario che scompaia il lavoro stabile, in ogni sua forma. Così che, in assenza di ogni forma di sicurezza sul proprio futuro, di ogni certezza sulla continuità del proprio reddito, ogni lavoratore affronti isolato, meglio ancora in competizione con gli altri, la ricerca quotidiana delle proprie fonti di guadagno. Il punto di riferimento non deve più essere il proprio compagno di avventura, con cui affrontare una lotta per migliorare le proprie condizioni di vita in virtù dei comuni interessi di classe, ma l’imprenditore che, grazie alla propria competenza in materia economica, alle proprie capacità di intrapresa e alla conoscenza dell’andamento dei mercati, può offrire le opportunità di lavoro e garantire lo sviluppo del paese, presentato tout court come l’interesse comune di tutti.
10.7 Insuccesso economico, ma sfondamento strategico
Il modello economico neoliberista, ben lungi dal risolvere i problemi posti dalla crisi della regolazione fordista, crea all’interno del sistema capitalistico contraddizioni insanabili. Il dominio del capitale finanziario, che in detto modello si attua, restringe i mercati internazionali, creando un collo di bottiglia per la produzione, già gravata da un regime di bassa inflazione e di alti tassi di interesse, che a lungo termine non trova soluzione. Ciò crea una competizione selvaggia, accentuata dalla caduta di ogni forma di pianificazione economica e dalla mobilità dei capitali, che tende, come tradizionalmente avviene, a generare crisi di sovrapproduzione. La massa di circolante e l’abbondanza di risorse da investire danno origine ad un surplus finanziario che, in assenza di sbocchi concreti, induce forme distruttive e di autentico cannibalismo capitalistico, col netto prevalere di forme puramente speculative. Il panorama così delineato appare poco brillante. In realtà due successi il neoliberismo ha conseguito. Il primo è l’accentramento della ricchezza in pochi oligopoli: periodi di esuberanza economica legati all’introduzione di nuove tecnologie o all’apertura temporanea di nuove occasioni di mercato, stimolano la nascita di una miriade di piccole intraprese legate all’inventiva dei singoli; nel momento in cui la congiuntura declina queste divengono preda dei monopoli finanziarie, se hanno prodotto applicazioni tecnologiche di interesse che vengono così capitalizzate a basso costo, altrimenti pagano in prima persona e duramente i costi della recessione (leasing e franchising sono i cappelli con cui il capitale finanziario controlla fin dall’inizio il cammino della piccola impresa, mai come adesso meno autonoma, mai come adesso funzionale alla mobilità del capitale che persegue il massimo di decentramento produttivo con il massimo di accentramento di potere). Il successo maggiore è comunque la frantumazione dell’avversario di classe. Una situazione di così esasperata concorrenza il capitalismo se la può consentire solo in assenza di un forte movimento dei lavoratori organizzato e cosciente. Di fatto, oggi, la resistenza di classe al progetto di dominio del capitale sorge spontanea in focolai, anche esemplari e talvolta continuativi, ma sparsi e isolati: retrocedono i movimenti operai forti del passato per lasciare ai margini bagliori di guerriglia, a volte eroica e disperata, a volte puramente reattiva e quindi oscillante tra reazione e criminalità. La lotta di classe diviene un problema puramente militare.
10.8 L'unica via d'uscita è la lotta salariale vincente
Se uno degli scopi prioritari del moderno assetto globale dell’economia è la frantumazione dell’avversario di classe, unica condizione per la quale la guerra della concorrenza può dispiegarsi in tutta la propria violenza, senza che la fragilità che ne deriva per il sistema capitalistico possa essere sfruttata per il suo abbattimento cosciente e strategicamente perseguito, scopo di un’organizzazione che si pretende rivoluzionaria è quello di ricostituire l’unità di classe del proletariato. Storicamente il terreno su cui la classe ha sempre costruito la propria coesione, la propria forza, la propria capacità di aggredire l’organizzazione del lavoro capitalistica, la propria possibilità di costruire alleanze con i ceti medi ed il sottoproletariato è stato quello salariale. Proprio l’abbandono della lotta salariale, la moderazione delle rivendicazioni, la subalternità agli obiettivi dalla controparte, hanno permesso, negli anni settanta e ottanta, il passaggio da una fase di attacco ad una fase di ripiegamento, sempre più vistoso della lotta di classe. Occorre quindi una nuova iniziativa nell’ambito del potere di acquisto per ricostruire fiducia, aggregazione e possibilità di invertire la tendenza alla continua perdita di potere del movimento dei lavoratori.
10.9 È una fase magmatica, ma un nuovo ordine è inevitabile
Come tutti i periodi di transizione, anche quello attuale è caratterizzato dalla coesistenza di spinte eterogenee, anzi spesso decisamente contrastanti. Le fasi di passaggio da un ordine complessivo del sistema ad un altro, da un equilibrio temporaneamente stabile ad uno diverso, può durare anche a lungo, ma l’attuale pare particolarmente lungo: In altre parole, non pare che l’assetto attuale corrisponda ad un sistema di relazioni economiche contenente germi di stabilità; anzi le contraddizioni innescate appaiono senza soluzione e tali da attivare processi violenti di dissoluzione. È inevitabile, pertanto, che osservando tra le pieghe dell’evoluzione economica, si incominci ad intravedere nel breve periodo le tracce di un nuova organizzazione del sistema capitalistico, che ne garantisca la sopravvivenza e l’autoalimentazione in un ciclo di sviluppo sufficientemente stabile per un buon periodo di tempo. Individuare le caratteristiche dell’emergente nuovo assetto è il compito che occorre prefiggersi.
10.10 Alcune indicazioni per l'agire
La FdCA intende promuovere le seguenti linee di azione per contrastare il crescente predominio pratico e culturale dell'economia della centralità del mercato: